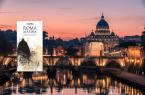La mostra Castel Sant’Angelo 1911–1925. L'alba di un museo promossa e realizzata dall’istituto del Ministero della Cultura Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma, in occasione del centenario dell’istituzione del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, avvenuta con Regio Decreto del 4 maggio 1925, ripercorre la stagione che va dal 1911 al 1925, quando prese avvio il progetto che trasformò il monumento in museo. Quella infatti fu una stagione cruciale, in cui la prospettiva di realizzare un museo – che all’inizio sembrava solo un sogno - si concretizzò nella realtà.
Il percorso della mostra vuole essere un omaggio a quell’esperienza, riunendo dipinti, sculture, rilievi, armi, acquerelli, stampe già esposti allora e oggi conservati in diversi musei e istituzioni italiane, accanto a materiali di Castel Sant’Angelo – in gran parte provenienti dai depositi – che costituirono il nucleo originario della collezione. Tutte le opere sono poste in dialogo con fotografie d’epoca degli allestimenti, che ne restituiscono il contesto e il significato.
Si tratta di una tappa fondamentale nella lunga e complessa storia di questo straordinario monumento, edificato come mausoleo imperiale e divenuto, nel corso dei secoli, fortificazione, residenza papale, carcere e caserma. La nascita del museo segna il momento in cui il monumento viene restituito a una dimensione prettamente culturale: una istituzione pubblica che, da allora come ancora oggi, si impegna a valorizzare l’edificio e le collezioni che custodisce, rivolgendosi ad un pubblico sia nazionale che internazionale.
Le origini di questo percorso affondano le radici in un altro momento simbolico: l’Esposizione del 1911, allestita proprio a Castel Sant’Angelo in occasione del cinquantenario dell’Unità d’Italia. Fu proprio allora infatti che il Castello venne trasformato in spazio espositivo, attraverso una mostra retrospettiva sull’arte italiana dalle origini al presente, che armonizzava, riunendole, archeologia, arti figurative, arti decorative, ambientazioni storiche e percorsi tematici. Un’operazione culturale e simbolica che, proprio per la sua ambizione narrativa e sperimentale, contribuì in modo determinante alla riorganizzazione del monumento nel suo nuovo ruolo.
L’allestimento si snoda in alcuni degli ambienti più rappresentativi del Castello: dalle Sale di Clemente VIII, alla Sala della Giustizia, fino all’appartamento di Clemente VII e alla splendida Sala di Apollo. Il percorso comincia con gli acquerelli di Ettore Roesler Franz (1845-1907), provenienti dal Museo di Roma, autore di vedute raffinate che documentano una Roma che stava ormai sparendo sotto le trasformazioni urbanistiche richieste dal suo nuovo ruolo di Capitale del Regno. Proseguendo, spicca poi lo straordinario dipinto di Umberto Prencipe (1845-1907), con veduta di Roma nel Quattrocento, proveniente dal Museo Boncompagni Ludovisi, concepito proprio per la mostra del 1911: le sue dimensioni monumentali infatti, il chiarore dell’alba che sta per sorgere e il respiro della composizione hanno ispirato il titolo della mostra odierna, L’alba di un museo.
Dalla collezione Gorga, anche questa al centro della mostra del 1911, sono presenti i celebri strumenti musicali, insieme ad reperti archeologici come un’affascinante stele tardoantica raffigurante un pretoriano. Quest’ultima, insieme alle eccezionali lastre romaniche scolpite, restaurate per l’occasione e restituite dai depositi del Museo delle Civiltà, rappresenta un omaggio alla sezione dedicata nel 1911 alla lavorazione del marmo.
Tra i dipinti cinquecenteschi spicca poi l’Elia nel deserto dagli Uffizi, opera di Daniele da Volterra (1503-1566), allievo di Michelangelo, che rende omaggio alla sezione “michelangiolesca” del 1911. Dalla Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Barberini proviene invece la Veduta del Tevere a Castel Sant’Angelo di Luigi Vanvitelli (1700-1773), immagine storica che lega il monumento al suo paesaggio urbano, mentre dall’Accademia di San Luca arriva una scultura in terracotta del Giambologna (1529-1608), allegoria di fiume, testimonianza del collezionismo accademico romano.
Una sezione specifica è dedicata a Bartolomeo Pinelli (1781-1835), artista che nella Roma dell’Ottocento seppe rappresentò i mestieri popolari e le scene di vita quotidiana: le opere esposte si inseriscono in un filone che, nella mostra del 1911, intendeva valorizzare le espressioni dell’arte e della tradizione popolare, documentando il volto più autentico della città.
Un grande spazio è inoltre dedicato alle armi e armature storiche, in dialogo ideale con la sezione “uomini in arme” del 1911. Accanto a prestiti prestigiosi – come due celate provenienti dal Bargello di Firenze – si segnalano numerose opere restaurate per l’occasione dai depositi del Castello: tra queste, una straordinaria armatura medicea della seconda metà del XVI secolo. Spicca in questa sezione il ritratto di Alfonso I d’Este di Battista Dossi (prima del 1500-1548), proveniente dalla Galleria Estense di Modena, figura nota per la sua passione per l’artiglieria.
Una sezione importante è dedicata a Giovan Battista Piranesi (1720-1778): le sue celebri Carceri d’invenzione, realizzate come metafora delle prigioni dell’anima, prendono idealmente ispirazione proprio dalle prigioni storiche di Castel Sant’Angelo. Le stampe, tirate appositamente dalla Regia Calcografia per la mostra del 1911, sono oggi esposte in un allestimento che ne sottolinea il legame con la funzione carceraria del monumento, affiancate da oggetti che ne evocano la storia.
La mostra si conclude nella magnifica Sala di Apollo, dove è stato riposizionato il grande plastico di Castel Sant’Angelo realizzato nel 1911, che osserva idealmente i busti marmorei di Adriano e Antonino Pio, legati alla fondazione e alla storia del Mausoleo. In un vano laterale, trova spazio l’angelo in legno dorato di Pietro Bracci (1700-1773), scelto come immagine simbolo dell’allestimento.
Il progetto, ideato dal Direttore ad interim del Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma, Luca Mercuri, si avvale del contributo di un comitato scientifico composto da Matilde Amaturo, Luigi Gallo, Ilaria Miarelli Mariani e Mario Scalini.
Foto: Daniele Ricciarelli, detto Daniele da Volterra (Volterra, 1509 – Roma, 1566), Il Profeta Elia nel deserto, 1543-1547, olio su tela, Firenze, Gallerie degli Uffizi, inv. 1890 n. 10744
Informazioni
Dal 23 settembre all'8 febbraio 2026dalle ore 9.00 alle 19.30ultimo ingresso alle ore 18.30Prima domenica del mese: accesso gratuito, non è prevista la prenotazionePer gli aggiornamenti e le modalità di visita consultare il sito > https://direzionemuseiroma.cultura.gov.it/museo-nazionale-di-castel-santangelo
 Condividi
Condividi