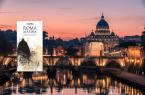Situata in piazza Capranica, nel cuore del Rione Colonna, la Chiesa di Santa Maria in Aquiro ha origini antiche, forse databili al V secolo.
L’appellativo “Aquiro” è di provenienza incerta: secondo la teoria maggiormente accreditata dagli storici, nasce dalla probabile alterazione di “A Cyro”, nome di una figura storica associata alla chiesa, mentre altre ipotesi si legano a “Equirria”, antica festività romana per il dio Marte, o ad “Aqua”, per la vicina presenza di un tratto dell’Acquedotto Vergine.
Nel tempo, fu oggetto di numerose ricostruzioni e restauri: citata nel Liber Pontificalis di Papa Gregorio III, fu ingrandita nell’VIII secolo per volere dello stesso pontefice «in qua antea diaconia et parvum oratorium fuit» (“dove in precedenza c'erano una diaconia e un piccolo oratorio”). Nel 1540, la chiesa, detta anche “degli orfanelli”, fu affidata alla Confraternita degli Orfani – approvata da Papa Paolo III con motu proprio nello stesso anno. L’istituzione caritatevole si prendeva cura dei bambini rimasti senza famiglia dopo il Sacco di Roma.
Alla fine del Cinquecento, il Cardinale Antonio Maria Salviati incaricò l’architetto Francesco Capriani da Volterra della ricostruzione della chiesa; i lavori, interrotti alla morte dell’architetto, furono ripresi nel 1601 da Carlo Maderno e Filippo Breccioli, il quale si occupò anche dell’ampliamento dell’orfanatrofio per ricavare un’ala adibita al nuovo Collegio che avrebbe garantito un’istruzione agli orfani più meritevoli. La parte superiore della facciata dell’edificio sacro, completata solo in parte da Maderno e Breccioli, fu portata a termine nel 1744 da Pietro Camporese il Vecchio. A partire della seconda metà dell’Ottocento, sotto il pontificato di Pio IX, la chiesa subì imponenti opere di restauro affidate a Gaetano Morichini e, per gli interni, al pittore Cesare Mariani.
La facciata a due ordini, affiancata da due campanili con cupolette, si distingue per i tre portali sovrastati da timpani – triangolare per quello centrale e semicircolari per i due laterali – nella parte inferiore. Nella parte superiore, una grande finestra è coronata da un timpano triangolare con due angeli che sorreggono uno stemma e, alla sommità, una croce al centro di due vasi fiammeggianti.
Gli interni a tre navate, divise da otto pilastri, presentano tre cappelle per lato e sono riccamente decorati con stucchi, dipinti e affreschi. Tra le opere si ammirano dipinti di Scuola Romana, Francesco Nappi, Carlo Saraceni, Maestro Jacopo, Anonimo Caravaggesco, Gherardo delle Notti (Gherard van Honthorst) e Giovan Battista Speranza. L’altare maggiore custodisce la splendida Madonna con Gesù Bambino e S. Stefano del XIV secolo della scuola del Cavallini, proveniente, come le lapidi nel vestibolo, dalla scomparsa Chiesa di Santo Stefano del Trullo.
Foto Redazione Turismo Roma
Informazioni
Per gli orari delle messe e le modalità di visita rivolgersi ai contatti indicati.
 Condividi
Condividi
Location
Per conoscere tutti servizi sull'accessibilità visita la sezione Roma accessibile.