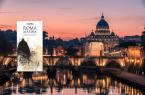Chi vi entrasse casualmente potrebbe forse sorprendersi nello scoprire che un’iconostasi (simbolo della distinzione tra cielo e terra) separa il presbiterio dalla navata e che le funzioni liturgiche seguono il rito orientale: da più di cento anni, San Salvatore alle Coppelle è infatti il punto di incontro della comunità greco-cattolica romena, oltre a essere la chiesa nazionale della Romania.
La chiesa dalla semplice facciata a un solo ordine che si incontra passeggiando tra le vie del Rione Sant’Eustachio, a metà strada tra piazza Navona e via del Corso, vanta tuttavia origini molto più antiche. La tradizione vuole che fosse stata edificata sulla casa della nobildonna romana Abbasia, che aveva lasciato in beneficienza le sue proprietà. Storicamente provata è invece la sua consacrazione o riconsacrazione a opera di Celestino III, nel 1195: a quest’epoca risalgono la lapide dedicatoria conservata all’interno e il piccolo campanile romanico, oggi in parte inglobato nell’edificio vicino. In una bolla di Onorio III del 1222 la chiesa è già chiamata “de Cupellis”, un nome che generalmente viene messo in relazione alla presenza delle botteghe di fabbricanti di piccoli barili, o coppelle.
Nel 1404 la chiesa fu affidata all’Università degli Orefici, Ferrari e Sellari. La confraternita si divise però nel giro di pochi anni: gli orafi finirono a Sant’Eligio degli Orefici e i fabbri a Sant’Eligio dei Ferrari, mentre i sellai rimasero qui per altri tre secoli, fino al 1740, quando cioè decisero di farsi costruire una nuova chiesa (Sant’Eligio dei Sellai, demolita nel 1902). Dal 1633 la chiesa era però anche la sede della Confraternita del Santissimo Sacramento della Divina Perseveranza, dedita a fornire assistenza a pellegrini e forestieri ammalati. Ancora visibile sul fianco sinistro della chiesa, una lapide a forma di buca per lettere invitava osti, albergatori e chiunque ospitasse forestieri a depositare un biglietto per denunciare i casi di malattia: “QUI DEVONO METTERE I VIGLIETTI TUTTI GLI OSTI ALBERGATORI LOCANDIERI ED ALTRI PER DARE NOTIZIA DE’ FORESTIERI CHE SI INFERMANO NELLE LORO CASE”.
La particolare cassetta postale risale al Giubileo del 1750: la maggiore affluenza di pellegrini rendeva probabilmente più pressante il problema di proteggere i visitatori e di tenere sotto controllo eventuali focolai di epidemie. Nel frattempo la chiesa medievale aveva subito una radicale trasformazione: era stata infatti riedificata in tempo per l’Anno Santo su progetto di Carlo De Dominicis, autore a Roma anche della facciata della chiesa dei Santi Bartolomeo e Alessandro dei Bergamaschi. A finanziare i lavori era stato il cardinale Giorgio Spinola, sepolto in una delle cappelle. Oltre allo spettacolare monumento funebre in marmo policromo per il cardinale, opera di Bernardino Ludovisi, la chiesa conserva due frammenti affrescati del Quattrocento (una “Dormitio Virginis” e una “Vergine con Gesù sulle ginocchia” della scuola di Antoniazzo Romano). L’interno, a tre navate, era originariamente suddiviso da colonne di marmo, sostituite alla fine del Settecento dagli attuali pilastri in muratura.
Foto turismoroma
Informazioni
Per gli orari delle messe e le modalità di visita rivolgersi ai contatti indicati.
 Condividi
Condividi
Location
Per conoscere tutti servizi sull'accessibilità visita la sezione Roma accessibile.